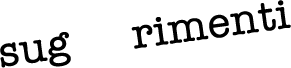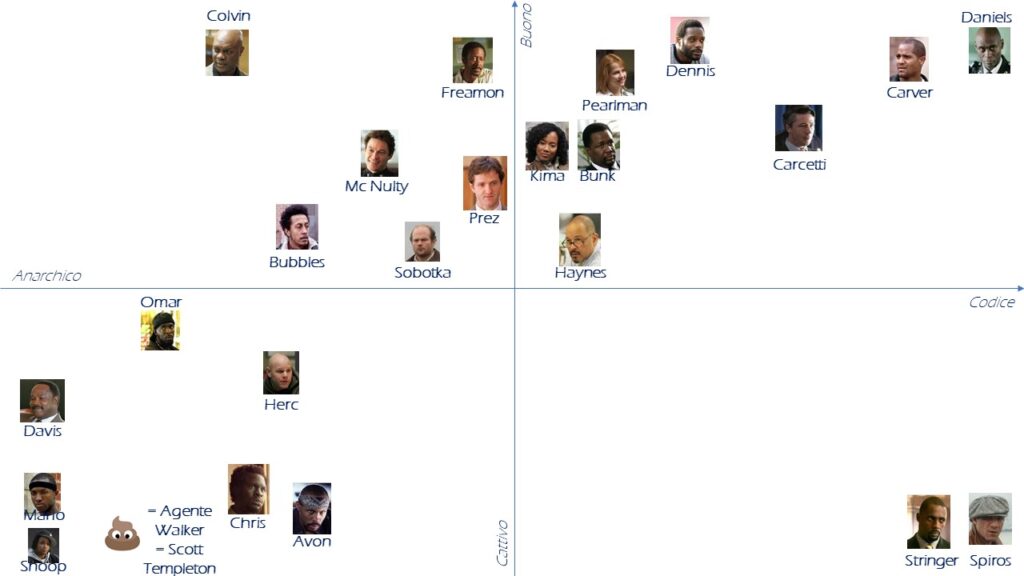BORIS 4

In questo post non parlerò di quanto dopo 11 anni in me ci fosse un conflitto incredibile tra l’attesa del Messia e il timore della delusione, come sempre succede quando qualcosa di epico viene ripreso dopo anni. Non parlerò del fatto che Boris è stata una delle cose più belle prodotte dalla TV in assoluto e abbia ben pochi concorrenti in Italia e che ha vivisezionato la TV dell’epoca regalando ai comuni mortali un affresco iperrealistico (a detta degli addetti ai lavori) di una produzione televisiva, ma mi concentrerò sulla nuovissima stagione e capirete se è il caso di guardarla o meno.
UN PO’ DI CAMBIAMENTI NEL CONTESTO
In 11 anni in Italia si sono susseguiti 9 governi e 2 presidenti della Repubblica, e nel mondo 2 papi, la Brexit, diversi attacchi terroristici, tra i quali l’elezione di Trump. I social sono diventati la principale fonte di popolarità. La TV e il modo di fruirne sono completamente cambiati con l’arrivo di svariate piattaforme streaming e il numero delle serie è cresciuto esponenzialmente. I vari competitor devono quindi alzare l’asticella per rimanere nel mercato: più risate, più lacrime, più ammiccamenti e una scrittura sempre più tagliente o proponendo format nuovissimi. Generazioni americane giovani di dirigenti che spostano il capitale in base al dinamismo e capacità di adattamento della produzione. La troupe di Boris ha perso due figure importantissime: Roberta Fiorentini, Itala l’assistente di produzione, e Mattia Torre, indimenticato sceneggiatore della serie, entrambi nel 2019. La quarta stagione di Boris (su Disney+ dal 26 ottobre) non poteva non tenere in considerazione tutte queste variabili. La domanda è una: Vendruscolo e Ciarrapico riusciranno a portare avanti a quattro mani un percorso iniziato a sei? L’assenza di Torre si farà sentire? La risposta non è così semplice, quindi racconterò un accenno di trama e le emozioni che mi ha suscitato, sperando di non ricorrere troppo agli SPOILERRRRRR.
ALGORITMI, GHOST, SNIP
Non c’è più la rete a supervisionare il progetto ma “la piattaforma”, che, attraverso un algoritmo (un’entità tra divinità e il direttor lup mannar gran figl di putt), decide ciò che può essere prodotto in base a diversi criteri: devono essere presenti un high concept (universale, di facile identificazione per tutti), la storia teen, il ghost del personaggio – il conflitto – e soprattutto il cast deve essere multietnico, in ottica di inclusione. Questi quattro elementi sono il motore della stagione e i personaggi si trovano a fronteggiare queste novità per restare nel mondo della TV. Il tutto, finanziato dalle due società QQQ (Qualità, qualità, qualità) di Diego con il cugino malavitoso calabrese, e la SNIP (So Not Italian Production) di Stanis e Corinna, che ormai formano una coppia di produttori/attori, sempre vanesi e scemi.
Negli 8 episodi, re-incontriamo tutti quelli che ci avevano fatto innamorare della fuoriserie nelle stagioni precedenti, compresi guest star come Nando Martellone (Massimiliano Bruno), Mariano (sempre sia lodato Guzzanti), Karin (Karin Proia), Cristina (Eugenia Costantini) e suo padre (Andrea Purgatori), Glauco (Giorgio Tirabassi) e troviamo un nuovo personaggio interpretato da Edoardo PESCE (ricordatevelo), Tatti Barletta, che dà un enorme contributo alla narrazione. E tutti i personaggi sono coerenti con i loro stessi del passato, il che rende ancora più esilarante il loro tentativo di inserirsi in un contesto così giovane e nuovo.
Ritorniamo a ciò che è cambiato negli ultimi 11 anni, che è riassunto dalle parole di Biascica “nel nostro mondo è cambiato tutto, dov’è finita la poesia di una volta?”. La qualità sostituisce il metodo “a cazzo di cane”, durante la produzione è sempre presente una ragazza che filma per il backstage, ovviamente non pagata, e non sono più tollerati gli episodi di nonnismo o sessismo, in virtù del politicamente corretto. Anche i tormentoni sono rinnovati, confermando l’originalità del prodotto.
RISATE E PIANTINI
Durante la sigla iniziale, anche questa nuova, fa un certo effetto la mancanza del nome di Mattia Torre tra gli sceneggiatori, anche se in tutti gli episodi avvertiamo la sua presenza, tra le risate e i piantini. Soprattutto risate, tantissime. La serie ha saputo reinventarsi e adattarsi ai nuovi scenari, ironizzando sulle abitudini degli italiani e trovando l’high concept che fa immedesimare anche chi non ha mai messo piede in una produzione TV. Mi rimane una domanda, che al momento non ha una risposta: a quando la quinta stagione?